Che un intellettuale apertamente ateo come Juan José Millás scriva su El País una colonna riconoscendo, anche se con ironia, la magnitudine ontologica del miracolo eucaristico dovrebbe provocare qualcosa di più di un sorriso imbarazzato nel mondo cattolico. Dovrebbe obbligarci a fermarci e a chiederci cosa sta fallendo quando persino un osservatore esterno rileva una profonda dissonanza tra ciò che la Chiesa afferma di credere e il modo in cui quel mistero viene vissuto —o banalizzato— nella pratica.
Millás non scrive come credente né pretende di esserlo. Proprio per questo la sua diagnosi risulta così rivelatrice. Parte da una premessa dottrinale corretta: la Chiesa insegna che nella consacrazione si produce un cambiamento reale, letterale, sostanziale. Non simbolico. Non metaforico. Un miracolo di primo ordine. E, tuttavia, constata qualcosa che chiunque può verificare: la scena abituale di molte celebrazioni liturgiche non riflette minimamente la trascendenza di ciò che lì accade. Gesti stanchi, distrazione generalizzata, routine. Come se nulla di straordinario stesse accadendo.
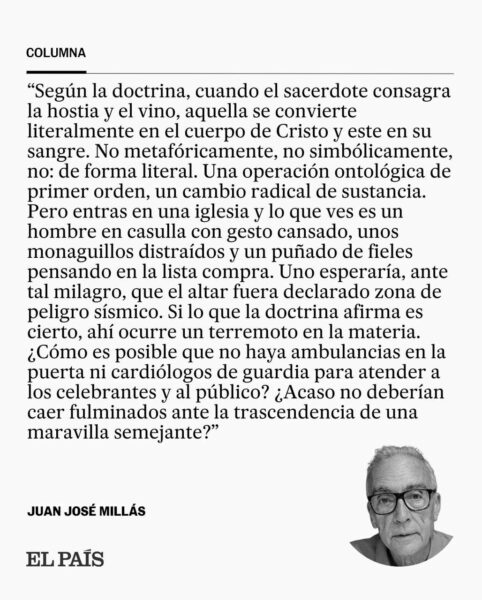
La domanda che formula —con sarcasmo, ma con logica— è devastante: se davvero crediamo a ciò che diciamo di credere, perché non agiamo di conseguenza? Perché non c’è tremore, stupore, timore reverenziale? Perché l’altare non sembra una zona sacra, separata, custodita?
Qui è dove l’osservazione esterna si trasforma in accusa interna. Non è l’ateo a banalizzare il mistero. Siamo noi. O, almeno, una forma di vivere la liturgia che ha eroso progressivamente il senso del sacro fino a renderlo quasi invisibile.
Non si tratta di esigere teatralità né isteria religiosa. Si tratta di coerenza. La Chiesa ha sempre saputo che il mistero esige custodia. Per secoli, sia in Oriente che in Occidente, si sono sviluppate forme concrete di proteggere il sacro: separazione del presbiterio, gesti precisi, silenzio, veli, segni di distanza. Non per disprezzo del popolo, ma per coscienza del mistero.
In Occidente, quella coscienza si è indebolita. E ciò che si è perso non è stata vicinanza, ma stupore. Non è stata partecipazione, ma reverenza. Quando tutto si mostra, tutto si banalizza. Quando nulla si protegge, nulla si venera.
Per questo risulta significativo —e preoccupante— che sia un non credente a segnalare l’incoerenza, perché percepisce una crepa evidente: una Chiesa che proclama il più grande dei miracoli e lo celebra come se fosse una formalità.
Il problema non è che il mondo non creda nell’Eucaristia. Il problema è che molte volte non sembra che la Chiesa stessa creda davvero in ciò che custodisce. E quando il mistero smette di strutturare la liturgia, finisce per diluire anche la fede.
Forse questa è una di quelle occasioni in cui conviene ascoltare persino chi parla dall’esterno. Per riconoscere che la crepa è così visibile che non passa più inosservata. Quando persino gli atei percepiscono la contraddizione, è segno che qualcosa di essenziale ha bisogno di essere corretto.
La domanda finale non è retorica: vogliamo continuare a spiegare il mistero o tornare a inginocchiarci davanti a esso? Perché la fede non si sostiene solo con parole corrette, ma con gesti che le rendano credibili.
